Un uomo pugliese veniva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia. L’uomo proponeva ricorso per Cassazione in quanto tali episodi altro non erano che espressioni della propria condizione e culturale in virtù della quale egli considerava la moglie e la figlia come “di sua esclusiva proprietà”. La difesa asseriva che le condotte violente dell’uomo, costituendo frutto delle condizioni sub culturali nelle quali era vissuto, escludevano il nesso psicologico necessario al fine di integrare i reati sopra menzionati.  I giudici di merito avevano accertato, nei due giudizi precedenti, che l’imputato aveva posto in essere le condotte offensive e violente, ai danni della moglie, fin dall’indomani delle nozze e le aveva protratte per oltre trenta anni. Sulla base delle argomentazioni esposte dal ricorrente, la Suprema Corte, con sentenza del 5 luglio 2011, nell’avallare la sentenza impugnata, evidenzia che le pretese tipiche del “padre e marito, padrone” non rilevano per l’accertamento dell’imputabilità, né ai fini dell’indagine sull’elemento soggettivo del reato. La Corte afferma che gli atteggiamenti oggetto della condanna rappresentavano “il costume abituale di un anacronistico pater familias maschilista e intollerante”, resistente al cambiamento del costume e noncurante della vigenza del principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi. Pertanto, i Giudici ritengono che la spiegata cultura non può rappresentare una scriminante o una circostanza attenuante, bensì è da ritenere quale elemento valutabile ai fini dell’intensità del dolo e dell’entità del danno sofferto dalla famiglia.
I giudici di merito avevano accertato, nei due giudizi precedenti, che l’imputato aveva posto in essere le condotte offensive e violente, ai danni della moglie, fin dall’indomani delle nozze e le aveva protratte per oltre trenta anni. Sulla base delle argomentazioni esposte dal ricorrente, la Suprema Corte, con sentenza del 5 luglio 2011, nell’avallare la sentenza impugnata, evidenzia che le pretese tipiche del “padre e marito, padrone” non rilevano per l’accertamento dell’imputabilità, né ai fini dell’indagine sull’elemento soggettivo del reato. La Corte afferma che gli atteggiamenti oggetto della condanna rappresentavano “il costume abituale di un anacronistico pater familias maschilista e intollerante”, resistente al cambiamento del costume e noncurante della vigenza del principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi. Pertanto, i Giudici ritengono che la spiegata cultura non può rappresentare una scriminante o una circostanza attenuante, bensì è da ritenere quale elemento valutabile ai fini dell’intensità del dolo e dell’entità del danno sofferto dalla famiglia.
I presunti condizionamenti socio-culturali non scriminano i maltrattamenti in famiglia
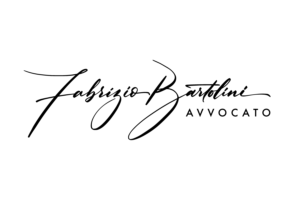
Vuoi saperne di più?
Richiedi una consulenza

